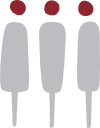Una nuova freccia per l’arco del docente di pianoforte
Fino al momento attuale le riflessioni sulla lettura a prima vista dello spartito per i pianisti si sono concentrate sugli aspetti di stretta correlazione fra scrittura e orecchio, fra significante e significato. In base a un fondamentale parallelismo che accomuna musica e linguaggio, infatti, ogni gruppo di segni scritti costituenti un insieme significativo (chunking) richiama alla mente un insieme significativo e noto di suoni (un frammento di scala o un arpeggio, per esempio). In base a questo presupposto, si è giustamente indirizzata l’azione didattica verso la decodifica non tanto dei singoli segni quanto dei loro raggruppamenti significativi, correlandoli con il loro risultato sonoro. È ormai chiaro che più un certo linguaggio musicale con i suoi elementi significativi è conosciuto, più esso può essere facilmente letto. Orecchio e occhio viaggiano di pari passo, per questo si è ampiamente sottolineato il ruolo dell’ear training nella prima educazione del potenziale futuro musicista. Allo stesso modo, il bambino prima di entrare nella rete scolastica primaria ha già acquisito i suoni della lingua italiana, conosce le parole e i loro significati; questo gli rende possibile leggere l’italiano e non una qualsiasi altra lingua di cui vedesse solo i segni. Per questo – nel momento in cui gli allievi principianti a noi affidati non abbiano a disposizione corsi specifici di ear training e improvvisazione – sarebbe interessante poter introdurre nelle nostre lezioni queste fondamentali pratiche che attivano connessioni indispensabili fra linguaggio musicale scritto e musica viva, fra segno e movimento, fra orecchio, occhio e mano.
Rimane tuttavia un’incognita: come mai – a parità di educazione e insegnamento – vi sono bambini che leggono con più difficoltà di altri i testi in lingua italiana, e come mai vi sono pianisti che rimangono lenti nella lettura? Come mai qualcuno – pur non avendo mai fatto corsi di improvvisazione o ear training – fin dalle prime lezioni di pianoforte acquisisce quello “sguardo fotografico” e quella “capacità di guardare avanti” che le ricerche associano al comportamento del lettore abile? E come mai molti altri pianisti acquisiscono queste abilità in troppo tempo e con troppa fatica? Lungi dal voler sminuire l’importanza della didattica sopra citata, questa constatazione non può che tradursi in un cambiamento del modo in cui si impostano le lezioni con i principianti, in modo da venire incontro allo stile di apprendimento di ogni allievo; d’altra parte, essa spinge la curiosità intellettuale a interrogarsi se esistano ambiti dell’apprendimento musicale e in particolare pianistico attualmente inesplorati. Come sappiamo, uno strumento quale il pianoforte, impegnando lo studente nella lettura contemporanea dei due righi (associata a due diversi comandi motori da dare sincronicamente alla mano destra e alla sinistra), evidenzia maggiormente la presenza di eventuali specifiche difficoltà.
Dalla riflessione su queste problematiche è nata una serie di ricerche e ipotesi.
L’essere umano è un “meccanismo” complesso e integrato, fatto di parti interconnesse; al pianoforte non si utilizzano solo l’apparato motorio e l’orecchio (finora i più specificamente “curati”, da una parte attraverso l’elaborazione di percorsi di ear training, dall’altra con lo sviluppo della cosiddetta “tecnica pianistica” nelle differenti scuole), ma anche l’occhio. Come già evidenziavo a pagina 61 del testo Metodologia dell’insegnamento strumentale: il pianoforte edito da ETS nel 2024, ho trovato estremamente interessante che una scuola montessoriana negli Stati Uniti abbia introdotto nei propri programmi educativi per bambini in età prescolare e scolare (Tweedlewink e Wink) degli esercizi di allenamento dei movimenti oculari. In seguito alla prima scoperta dell’esistenza di vari visual training in ambito educativo, la domanda – o intuizione – che ha guidato la mia ricerca è stata la seguente: se educando l’orecchio e correlando a sua volta il suono al “gesto sonoro” (e il gesto al segno), si potenziano negli allievi le capacità di lettura e la velocità di decodifica, cosa potrebbe modificarsi d’altra parte nello sviluppo delle capacità uditive e gestuali allenando specificamente la visione?
È da qui che sono partita con entusiasmo a esplorare l’ambito del cosiddetto “visual training”, cercando la consulenza di esperti di visione e imbattendomi successivamente nello “sports vision”, un training visivo mirato – ed ecco l’originalità – non alla cura della patologia ma al potenziamento delle abilità visive implicate in modi differenti nelle performance dei singoli sport.
La pratica dello sport vision affonda le sue radici negli Stati Uniti d’America, in ambito optometrico: durante la seconda guerra mondiale fu per la prima volta sperimentato un training visivo sugli aviatori, training che nei primi anni ’60 fu esteso agli atleti (nel 1960 un optometrista fu ufficialmente assunto per allenare la squadra di baseball dei Cincinnati Reds; un allenamento visivo ancora più massiccio fu introdotto per il potenziamento della squadra di hockey su ghiaccio New York Islanders). A partire da queste prime applicazioni basate sull’intuizione di poter potenziare le abilità visive, gli optometristi statunitensi arrivarono negli anni ’80 a consolidare il fenomeno trasformandolo in una vera e propria disciplina e denominandolo col termine “Sports Vision”; sempre negli USA sono nati i primi istituti di formazione che hanno promosso il diffondersi delle terapie visive: il College of Optometrists and Vision Development, la Optometric Extension Program Foundation, la Baltimore Academy of Behavioral Optometry. Il primo a introdurre in Italia – in ambito sportivo – le metodologie dello Sports Vision, grazie anche alla collaborazione con professionisti americani, è stato il prof. Vittorio Roncagli, che ha promosso la fondazione nel 1988 dell’Accademia Europea di Sports Vision (EASV) e nel 1989 del primo centro operativo di Sports Vision in Italia, con sede a Cervia. In seguito, sempre in ambito italiano, nel 2013 è stato brevettato il metodo SVTA (Science Vision Training Academy), un approccio allo Sports Vision che mira a integrare il sistema visivo, cognitivo e motorio. Lo SVTA è nato dall’esperienza di Andrea Cagno, un optometrista sportivo-comportamentale, e ha avuto importanti applicazioni anche nell’ambito del lavoro con i DSA; esistono in Italia professionisti dell’ambito sanitario, formati nel metodo SVTA, che si dedicano ad aiutare i bambini con diversi disturbi dell’apprendimento o con autismo, come ad esempio la dottoressa Sara Toma di Milano.
Come tanti hanno già sottolineato, “vedere 10/10” non è sinonimo di “avere delle abilità visive performanti”; i 10/10 indicano l’acuità visiva statica, ovvero la capacità dell’occhio di vedere i dettagli.
È importante infatti distinguere tra “vista” e “visione”. La vista è l’abilità di percepire chiaramente i dettagli, spesso misurata con l’acuità visiva. La visione, invece, è un processo più ampio che include l’interpretazione di ciò che vediamo, la percezione dello spazio, la coordinazione occhio-mano-corpo, percezione periferica, motilità oculare, movimenti saccadici e di inseguimento, fissazione e messa a fuoco, memoria visiva.
Queste abilità visive potrebbero interferire in una lettura scorrevole al pianoforte.
Dopo aver raccolto un piccolo team composto di docenti ed esperti di visione / sports vision, mi sto attualmente occupando di coordinare una ricerca e di ideare alcuni esercizi mirati a potenziare le abilità visive necessarie al pianista; abbiamo chiamato MUSIC VISION questo nuovo progetto formativo mirato al potenziamento generale delle performance di lettura per i pianisti. Il lavoro si sta rivelando estremamente interessante ma non breve, data la stretta correlazione di abilità implicate (a partire dalle abilità neuro-cognitive come l’attenzione e la memoria a breve e lungo termine, passando attraverso il riconoscimento uditivo , le abilità psicomotorie e le varie abilità visive, insieme a quelle visuospaziali e di discriminazione).
Il programma specifico di potenziamento verrà messo a punto e portato avanti in una prima sperimentazione durante il prossimo anno scolastico, ed eventuali frutti che interessino la comunità didattica musicale verranno condivisi successivamente. La speranza è che queste piccole scoperte vadano a incrementare il numero delle frecce per l’arco del docente, dove il bersaglio da raggiungere è il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni allievo.
>>> contatto con l’autrice: assini.antonietta@consaosta.it