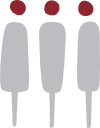Coniugare il lavoro sociale ed educativo per la costruzione di cittadinanza allo specifico musicale
Cittadinanza è un termine ricco di significati: assume in sé la facoltà di esercitare dei diritti e l’obbligo di adempiere alcuni doveri.
Avere cittadinanza significa vedere riconosciuta la propria cultura, poter esercitare i propri diritti civili, sindacali, politici, culturali ma anche partecipare attivamente alla trasformazione della società, nel rispetto degli altri cittadini, delle loro culture e dell’ambiente, superando personalismi e particolarismi.
Costruire cittadinanza è quindi un lavoro di grande importanza, in generale all’interno della società e più in particolare nella scuola e nel mondo dell’educazione. E’ naturale quindi chiedersi, per chi lavora nel campo della musica, se possa esistere una “carta delle cittadinanze musicali”, che coniughi il lavoro sociale ed educativo per la costruzione di cittadinanza allo specifico musicale e che espliciti quali possano essere i punti di articolazione della cittadinanza musicale. La domanda è tanto più pressante se si considera la grande varietà delle culture musicali, dei generi, degli stili, delle pratiche sociali intorno alla musica che attraversano le società. A questa grande varietà fa tuttavia riscontro, sia sul piano della vita sociale (stampa, radio, tv, concerti, ecc.) sia su quello scolastico, un atteggiamento di segregazione culturale, in base al quale alcune culture, generi, stili e pratiche sono accettati e promossi e altri invece ignorati e/o rimossi.
E’ ormai diventato abituale, sotto la spinta dell’immigrazione e dello sviluppo della comunicazione a livello planetario pensare alla musica come terreno di esercizio dell’incontro tra le diversità culturali, sia diretto che virtuale. Tuttavia è limitante pensare che la costruzione di un rapporto tra culture, attraverso la musica, avvenga solo tra persone di storia diversa per provenienza geografica, religiosa o macroculturale. L’incontro interculturale attraverso la musica avviene, anche tra generazioni, sessi e sottoculture di gruppo e non solo tra persone provenienti da paesi lontani tra loro. Anche questo rende difficile articolare una “carta delle cittadinanze musicali”; tuttavia questa difficoltà, proprio perché dovuta al forte legame della musica con molteplici pratiche sociali e con le storie di vita degli uomini e delle donne rende al contempo più stimolante il compito.
Proviamo quindi a formulare la proposta di alcuni punti per “una carta delle cittadinanze musicali” intendendo la sua definizione come un progetto aperto, su cui invitiamo a esprimersi educatori e operatori musicali.
1- TUTTE LE CULTURE E LE ESPRESSIONI MUSICALI HANNO DIRITTO DI CITTADINANZA
Il diritto di cittadinanza va riconosciuto a tutte le culture musicali, indipendentemente da ogni valutazione storica, sociale o estetica. Tutte le culture musicali sono espressione di bisogni, identità individuali e collettive, testimonianza di una condizione umana e sociale in cui interagiscono infiniti fattori di diversa natura e origine. Tutti i singoli e i gruppi devono quindi rispettare le diverse espressioni musicali e a loro volta essere rispettati e ascoltati. La società delle cittadinanze musicali non si accontenta della tolleranza ma la oltrepassa, perché assume come valore il mutare e il trasformarsi nell’incontro tra le culture, egualmente, si riconosce a tutti il diritto a prendere la parola e a esprimersi criticamente. Al contempo, si accetta come normale anche il conflitto tra le culture, ma ci si impegna affinché tale conflitto venga risolto in modo non distruttivo per nessuno.
2- PROMUOVERE I BISOGNI E LE IDENTITA’ MUSICALI
Tutti gli uomini e le donne esprimono bisogni e identità musicali. E’ necessario che, nella scuola e nella società, i bisogni musicali di ciascuno (fare, ascoltare, studiare, parlare di musica) possano essere soddisfatti e che le diverse identità possano liberarsi.
Nella rappresentazione simbolica delle esperienze e dei vissuti che si condensa nella musica trova articolazione l’incontro tra diversi stili cognitivi e comunicativi e tra diversi modelli di interpretazione della realtà; questo è un terreno di realizzazione ma anche di modificazione delle diverse identità nel costante confronto con l’altro.
3- RICONOSCERE LA MOLTEPLICITA’ DELLE FUNZIONI DELLA MUSICA
In ogni cultura, e all’interno di ciascuna di esse nei diversi periodi storici, la musica ha diverse e molteplici funzioni. La musica può “servire” a raccontare, a esprimere stati d’animo, a coordinare dei movimenti, come nel caso dei canti di lavoro e della musica per danza. La conoscenza e lo studio delle funzioni della musica è una buona via per comprendere le identità e le somiglianze tra le diverse culture musicali. La maggior parte delle funzioni è comune a molte culture, anche se le forme concrete delle musiche che fanno riferimento a tali funzioni sono alquanto diverse l’una all’altra. La grande diversità delle musiche che rispondono alle stesse funzioni ma che provengono da culture diverse deve essere accettata e valorizzata come espressione della varietà della condizione umana che esse esprimono.
4- VALORIZZARE LE PRATICHE SOCIALI IN CUI E’ PRESENTE LA MUSICA
La musica è parte integrante di molte e diverse pratiche sociali (le cerimonie, la politica, la religione, la narrazione, l’intrattenimento, lo sport, il concerto….). Queste pratiche, all’interno della società borghese europea sono gerarchizzate e al punto più alto della scala di valori è posta la pratica del concerto (e quella della composizione), destinata a pochi “geni”. Si tratta di una riduzione indebita della ricchezza e del significato dell’esperienza musicale nella vita degli uomini e delle donne. E’ invece importante valorizzare tutte le pratiche sociali in cui è presente la musica perché esse esprimono la profonda integrazione della musica nella vita individuale e sociale. Inoltre, valorizzare le pratiche sociali concorre a promuovere le diverse identità musicali, che propongono diversamente e in contesti differenti il proprio bisogno di esprimersi con la musica.
5- VALORIZZARE LE AUTOBIOGRAFIE E LE BIOGRAFIE MUSICALI
La musica, nella vita degli uomini e delle donne, può occupare un posto diverso: può essere un ambito di realizzazione professionale, una passione importante, limitarsi alle dimensioni del tempo libero, della socialità o dell’affettività. Tuttavia, per chiunque, l’esperienza della musica e con la musica costituisce una traccia, più o meno marcata e significativa, che è possibile seguire nella ricostruzione della propria autobiografia, scoprendo quanto essa sia capace, anche se in forme diverse, di dare significatività alla vita. Inoltre, il tipo di rapporto con la musica, i diversi e molteplici atteggiamenti e gusti musicali che si succedono nella vita segnano trasformazioni nel modo di percepire la realtà, avvertono di modificazioni cognitive e di atteggiamenti mentali, rivelano incontri e cambiamenti di interessi e punti di vista.
Valorizzare le autobiografie e le biografie musicali significa quindi mettere in luce che la vita musicale di tutti è importante e significativa e che non esistono persone che non hanno nulla da dire a proposito della musica.
6- RICONOSCERE COME NORMA LA TRASFORMAZIONE NEL CONTATTO CULTURALE
Nessuna cultura può dichiararsi “autentica” e incontaminata. Tutte le culture sono esito di infiniti incontri e scambi: parlare della “autenticità” di un prodotto culturale significa cristallizzarlo sottraendolo al carattere di flusso in continua trasformazione che caratterizza le culture vive. La musica, in particolare, è un terreno particolarmente fertile per l’acculturazione, per la nascita di prodotti ibridi, per l’integrazione di contributi diversi nelle varie culture, per i “prestiti” culturali. Nessuna cultura può vivere e arricchirsi senza vivificarsi e fecondarsi nell’incontro con l’alterità, anzi qualsiasi prodotto musicale è necessariamente ibrido se lo si esamina nella sua prospettiva storica. Difendere presupposte autenticità e genuinità della propria cultura significa implicitamente negarne la vitalità e al tempo stesso negare il contributo che ad essa è venuto dalle altre culture.
7- SALVAGUARDARE IL DIRITTO ALLA DIVERSITA’ MUSICALE
Se l’acculturazione, lo scambio e l’ibridazione devono essere riconosciuti come normalità nei rapporti tra le culture, deve egualmente essere tutelato il diritto alla diversità musicale, individuale e collettiva. Sul piano individuale, ciò significa dare cittadinanza a chi sceglie strade personali e originali per l’espressione della propria musicalità. Sul piano collettivo, invece, è necessario opporsi all’omologazione delle culture a modelli imposti dall’esterno. Così come sono da valorizzare la curiosità verso le altre culture musicali, il desiderio della ricerca e dell’incontro, l’attivazione di momenti di confronto e di scambio, sono da combattere le operazioni eterodirette di carattere commerciale, le mescolanze forzate, l’imposizione di modificazioni di genere e stile in nome del mercato. Avere cittadinanza significa, come abbiamo già accennato, avvertire anche il dovere di tutelare il pluralismo culturale, di prendersi cura delle espressioni diverse dalle proprie e non solo vedere riconosciuti i propri diritti. La società delle cittadinanze musicali, pertanto, deve tutelare chi decide di rifiutare queste operazioni, anche in ragione del fatto che la pluralità delle voci è garanzia di futuri, ulteriori incontri ed evoluzioni.
8- RICONOSCERE NELLA MUSICA UN TERRITORIO DI APPROSSIMAZIONE
L’approssimarsi all’alterità è un movimento discreto, di ricerca e di curiosità, che precede l’incontro. E’ l’entrare nel territorio di frontiera, prima di varcare il confine. Prima del vero contatto, dell’incontro pieno tra le culture, l’approssimazione è il primo percorso da compiere, rispettoso e sereno.
BIBLIOGRAFIA
– Bencivenga E.: Oltre la tolleranza, Milano, Feltrinelli, 1992
– Blacking J. 1973: How musical is man? University of Washington Press, 1973 (trad. it.: Come è musicale l’ uomo?, Milano, Unicopli Ricordi, 1986)
– Disoteo M.: Didattica Interculturale della Musica, Bologna, EMI, 1998
– Disoteo M., Ritter B., Tasselli M.S, Musiche, culture, identità, Milano, Franco Angeli, 2001
– Disoteo M.: Antropologia della musica per educatori, Milano, Guerini & associati, 2001
– Disoteo M., Piatti M.: Specchi sonori. Identità e autobiografie musicali, Milano, Franco Angeli, 2002
– Fabietti U.: L’identità etnica, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1995
– Gallissot R.-Rivera A.M.: L’imbroglio etnico, Bari, Dedalo, 1997
– Giuntini G. (a cura di): “La musica, la strada, la piazza. Il nuovo spettacolo metropolitano: un invito all’ accoglienza e alla tolleranza”, in Progetto Uomo-Musica n. 6, luglio 1994
– Piatti M. (a cura di): “Identità Musicali”, in Progetto Uomo-Musica n. 5, gennaio 1994
– Piatti M. (a cura di): Io-tu-noi in musica: identità e diversità, Assisi, Pro Civitate Christiana, 1995
– Piatti M. (a cura di): Pedagogia della musica: un panorama, Bologna, CLUEB, 1994