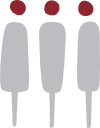Musicheria: Per tanti anni hai insegnato nelle Scuole di Didattica della musica dei Conservatori e poi sei approdato alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento, di cui sei stato anche Preside. Qual è il tuo punto di vista in merito ai rapporti tra “pedagogia” e “musica”?
Salvatore Colazzo: Pedagogia e musica, o pedagogia generale e pedagogia musicale? Sono evidentemente due questioni differenti. Assumo la domanda nella prima accezione. Della seconda ho discusso alcuni anni fa nel saggio “Del rapporto Pedagogia musicale – Pedagogia generale” uscito sulla rivista “Studi sulla formazione” (Anno VIII, n. 2, 2005) che all’epoca era diretta da Franco Cambi.
Io da docente di Conservatorio ho studiato ed approfondito la musica del Novecento, soprattutto del Novecento delle avanguardie, ma poi anche John Cage, il minimalismo, il postmoderno. E da filosofo (io provengo da severi studi filosofici) mi sono lasciato affascinare dal dibattito sulla fine della metafisica. Ricordo che in particolare modo un testo mi aveva catturato, Rorty, La filosofia dopo la filosofia. Una volta che arriviamo a considerare la filosofia qualcosa di simile ad un genere letterario, che consideriamo illusorio il suo desiderio di pervenire alla natura ontologica della verità, una volta che concepiamo la verità come una costruzione, come risultato anche – ce lo ha insegnato Foucault – dei rapporti di dominio fra gli uomini, come continuare a praticare la filosofia, l’estetica, la critica? Pensavo: abbracciando la militanza culturale, praticando il giornalismo, dialogando con gli artisti, esplorando le loro poetiche, capendo il loro posizionamento nel mondo, impegnandosi in operazioni creative, soprattutto condividendo con altri il senso delle proprie avventure (da qui la mia vocazione per la pedagogia e la mia insofferenza per il pedagogismo, lo scolasticismo e il disciplinarmente accademico). La mia pedagogia è quella di una persona in cammino, che si impegna in un’opera di de-costruzione della propria disciplina, che studia più le condizioni della sua impossibilità che quelle della sua istituzionalità. La mia pedagogia vive nell’incertezza del divenire, come l’arte che è flusso, equilibrio trovato una volta e poi perduto per dover essere ancora cercato e ritrovato.
A me la musica ha insegnato essenzialmente quali debbano essere le fondamentali questioni pedagogiche. Nella relazione educativa – ho appreso – va considerato il coinvolgimento del corpo e l’impatto emozionale col sapere. La relazione educativa poi è una sorta di danza attraverso la quale il docente e l’allievo realizzano un complesso reciproco equilibrio, dinamico, sempre da recuperare. Da pedagogista ho studiato l’enattivismo, le teorie dell’embodied cognition. Credo non a caso. Altro tema: gli strumenti e le tecnologie come fondamentali mediatori del pensiero e della creatività. La musica ci insegna questo: sin dalle sue origini il rapporto del soggetto con il suono è stato veicolato dallo strumento. In questo, il suono manifesta la sua doppia natura, di un qualcosa di sensibile, materiale, che però immediatamente assume una valenza, vien da dire, spirituale. Espresso in altri termini, mette in contatto e integra le diverse dimensioni del soggetto: fisico-corporee ed emotive, cognitive e simboliche. Si possono ricavare immediate conseguenze, da questi discorsi, sul piano pedagogico e metodologico. E procedendo, la rilevanza dell’ascolto. Una relazione educativa deve prevedere, da parte del docente, una buona dose di ricettività, da intendersi come capacità di far risuonare l’altro in sé; nonché favorire nell’allievo la disponibilità ad autoascoltarsi ed entrare in rapporto con l’altro facendosene un’idea (da intendersi nel senso etimologico del termine). La creatività musicale, misurandosi con il suono, è alimentata dalle potenzialità di forma che il suono reca con sé, quindi deve essere in grado di porsi in ascolto della materia e seguirne le sue intenzioni di realizzazione. La musica – se riflettiamo bene – è stata la prima verifica che l’uomo ha fatto della possibilità di regolare le proprie emozioni, ed è stata la prima sperimentazione di modellazione di un mondo virtuale, altro, da abitare col proprio corpo, entrando in uno stato di trance. Oggi siamo in grado di fare della multimedialità una musica, stiamo imparando a costruire un mondo polisensoriale, per immergerci dentro, sospendendo la cosiddetta realtà. Come i primitivi facevano con la loro musica e i loro riti.
M.: Nella relazione che hai tenuto a Gorizia nel 1994 – che pubblichiamo in allegato – discuti dell’evoluzione della pedagogia musicale dagli anni 60’ – legata, come scrivi, “a far provare agli allievi piacere e gioia per il bello” – a una visione strutturalista e linguistica negli anni ’70 (Della Casa e Delfrati), con evidenti legami alla semiologia (Stefani), fino ad evoluzioni successive. Come si caratterizza oggi quella che possiamo denominare “Pedagogia della musica”, o “Pedagogia musicale”? E ritieni utile e possibile distinguere “Pedagogia della musica” da “Didattica della musica”?
S.C.: Per me oggi la Pedagogia musicale deve prendere atto di un paio di eventi epocali, che segnano una profonda discontinuità rispetto al passato: a) la compresenza, favorita dai processi migratori e dai fenomeni legati alla comunicazione interattiva e multimediale, di differenti, concomitanti culture, le quali costituiscono un ambiente a suo modo babelico, che tuttavia sollecita fortemente la creatività, favorendo attività di bricolage, di contaminazione, che scavalcano distanze spaziali e temporali, rendendo tutto in qualche modo contemporaneo, in ragione della co-presenza di stili, generi, forme e manifestazioni del suono; b) la preminenza della musica registrata, trattata elettronicamente, che modifica profondamente le esperienze di ascolto, e la sua diffusività: non c’è ambiente o momento della giornata che non sia accompagnata dalla presenza della musica. Le conseguenze da un punto di vista pedagogico sono chiare: il concetto di musica si è enormemente dilatato, si potrebbe dire che interessarsi di musica è interessarsi del suono nel senso più ampio e della modellazione culturale plurima che ad essa i gruppi sociali attuano; il concetto di bello e di brutto sono categorie sostanzialmente inservibili, conta ciò che gli uomini concretamente fanno della musica e ciò che gli uomini fanno con i suoni denominandolo musica; la musica ha una capacità di interessare, intrigare, attrarre gli uomini e le donne odierni, prestandosi come poche altre attività a sviluppare le potenzialità cognitive ed emotive.
Mi chiedi della distinzione Pedagogia/Didattica musicale. Questa distinzione varrebbe la pena mantenerla, nel senso che la Pedagogia musicale inquadra epistemologicamente le questioni, mentre la Didattica ha una postura più orientata al fare educativo, sebbene la Pedagogia e la Didattica debbono considerarsi in constante scambio, per il tramite della ricerca educativa, che è il terreno d’incontro tra l’una e l’altra.
M: In questi ultimi anni il tuo impegno di studioso e di educatore si è dedicato all’ideazione e alla realizzazione della “Summer School di Arti performative e community care”, riprendendo, mi pare, le suggestioni conclusive della tua relazione del 1994, in cui scrivevi: «È possibile fare scuola fuori dalle aule scolastiche? Il territorio è ricco di opportunità formative. Si tratta di imparare a sfruttarle. La realizzazione di una scuola fuori dalla scuola per riuscire non deve essere sentito unicamente come un compito della scuola. Deve essere avvertito come un compito, un’esigenza sociale. Bisogna insomma acquisire alla scuola nuovi livelli di “autonomia”, “decentramento” e “partecipazione”». Mi pare molto attuale questa esigenza, in relazione anche alle tendenze relative alla Community Music e alla valorizzazione dell’Animazione Musicale (come ha documentato anche Enrico Strobino nel suo articolo “Community Music e /o Animazione Musicale” (https://www.musicheria.net/2023/08/27/community-music-e-o-animazione-musicale/). Che ne pensi?
S.C.: Io sono convinto – e non da oggi – che bisogna saper cogliere e valorizzare l’educativo ovunque esso si manifesti. L’essere umano è tale poiché educabile. Ed è educabile contro la sua stessa volontà. Si completa necessariamente nella relazione con l’altro. Mancando questa, egli non ha possibilità di sviluppare le proprie potenzialità, che rimangono immancabilmente inespresse. Ogni soggetto prende forma nello scambio che si stabilisce tra lui e la società. Egli vive attivamente in una cultura, è questo il dato precipuo. La scuola è un prodotto storico, nel senso che essa è un modo attraverso cui si concretizza il rapporto tra il soggetto e la propria cultura. È importante non considerare la scuola come esaustiva della formatività del soggetto. Oggi poi i media rendono il nostro ambiente ricco di informazioni, le più diverse, in concorrenza fra di loro, ma anche di fluidi emotivi: i nostri sensi sono continuamente stimolati, la nostra sensibilità permanentemente sollecitata. Immersi in una artificialità multicolore, polifonica, che fa sì che ogni nostra esperienza sia culturalmente mediata, ma non univocamente definita. David Bolter non a caso ha parlato di “plenitudine digitale”. I media ci gettano in un universo molteplice di forme comunicative: siti web, videogiochi, libri da leggere o da ascoltare, programmi televisivi e radiofonici, giornali e riviste e abilitano una pluralità di pratiche con i materiali culturali con cui entriamo in contatto. Non c’è una cifra che possa unificare questa moltitudine. Certamente ciò che decretano come non sostenibile è l’idea che esista una cultura che ha maggior diritto di dirsi cultura: le gerarchie che consentivano un tempo di parlare di cultura propriamente detta e di culture subalterne sono defunte. Possiamo anche amare la “musica classica”, ma sappiamo bene che non è possibile sostenere questo nostro amore con una pretesa di universalità. Facciamo parte di una minoranza, a cui è consentito di esprimersi allo stesso modo di altre minoranze. Ma non può immaginare di imporsi nella società e nella scuola. Questa ha un senso nel consentire condivisione di esperienze, nel dare la possibilità di agire nella ricchezza dell’universo mediale senza smarrirsi del tutto, accompagnando i soggetti nel loro sforzo di costruire la propria identità (necessariamente aperta) con i frammenti culturali che galleggiano nello spazio ipermediale. La forma precipua dell’apprendimento è il bricolage. Da qui la preminenza del fare. La riflessione stessa non precede l’agire, ma lo accompagna, è riflessione nel corso del fare e sul fare, per immaginare nuove esperienze.
La Summer School di Arti Performative e Community Care (da quest’anno Scuola di Arti Performative e Community Care) a cui facevi segno si propone, sin dal suo inizio, come un’esperienza di ricerca-formazione-intervento, per mettere in connessione culture e forme dell’essere. Per imparare nel campo dell’agire educativo e sociale è indispensabile gettarsi nel mondo della vita, la ricerca è l’esito della riflessione che non può svolgersi a vuoto, in un ambiente anodino, qual può essere quello accademico, ma deve essere uno stare in situazioni per comprenderle e comprendersi. Ecco dunque che il ricercatore trova la sua realtà da studiare in una comunità locale, fatta di persone in carne e ossa, che vivono la loro quotidianità e vivendola la riflettono. Ma il ricercatore deve essere disposto a formare alla ricerca, deve trasferire il suo sapere ad altri, implica dunque nella ricerca giovani studiosi e li fa partecipi di una sensibilità e di un metodo. Se ci si vuole formare alla ricerca bisogna condividere una situazione, che, caratterizzata da diversi gradi di expertise, si qualifica come una “comunità di pratiche” in cui, facendo assieme, il sapere si trasferisce e si moltiplica. E tutto ciò è intervento, su un oggetto di studio, che però è un soggetto, e quindi una realtà viva che viene coimplicata nella ricerca e nella formazione. La complessità di un simile dispositivo – che Ada Manfreda ed io abbiamo modernizzato, denominandolo ACL® (Action Community Learning) consente che una comunità di ricerca in formazione si confronti con una comunità territoriale, dentro una prospettiva di co-ricerca, che fa sì che l’elemento riflessivo consenta ad entrambe le comunità di trasformarsi, in modalità in gran parte imprevedibili.
Oggi qualsivoglia azione educativa deve stare dentro una complessità del progettare e delle pratiche messe in essere. Complessità del progettare significa che non c’è progetto che possa arrivare alla meta per come inizialmente definita, strada facendo è destinato inevitabilmente a cambiare. Bisogna saper veleggiare. Non c’è più la possibilità di trasferire sapere linearmente. La consequenzialità è saltata, siamo in un ambiente saturo di suoni (uso suoni metonimicamente: la parte per il tutto) provenienti da ogni dove, suoni co-presenti, ognuno con un suo carattere e tutti assieme a costituire un’inattesa composizione. Dentro questo polifonico, talvolta disorientante, talaltra assordante, universo siamo immersi, ogni movimento che facciamo, con la nostra testa, col nostro corpo, modifica la sua fenomenologia, perciò bisogna scegliere le traiettorie per noi più consone, che cioè rispondono meglio alla nostra sensibilità. Dobbiamo imparare a trascegliere, selezionare, interagire. E la misura non ci viene dettata dall’esterno, siamo noi a determinarla, secondo i nostri gusti, secondo le nostre possibilità, secondo i nostri (supposti) bisogni. Tutto questo è insieme disorientante e anche però eccitante. Ci immerge in una sorta di dionisismo. Di Dioniso, si sa Pan è compagno. Mi chiedo e vi chiedo: che ne è della pedagogia musicale in questo Caos inquietante? Ho come l’impressione che debba essere una sorta di accompagnamento rituale che aiuta i soggetti ad incontrare il sé più profondo, andando incontro alla ricchezza incontenibile del mondo.